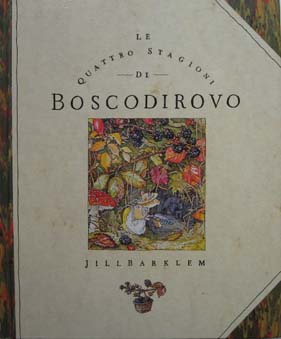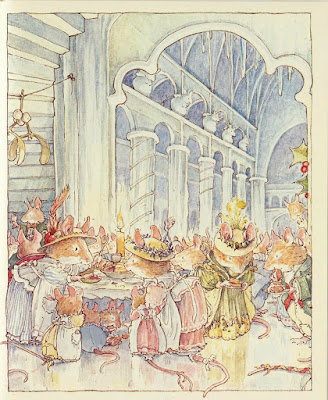Numero pagine: 128
Lingua originale: italiano
Prima
edizione: 1954
Genere: saggio
Interessandomi sia di religioni antiche che di
spiritualità femminile, anni fa mi è capitato di imbattermi nelle
teorie di Uberto Pestalozza e del suo entourage, fra cui anche
Momolina Marconi. Per varie vicissitudini, pur conoscendo
sommariamente il suo pensiero non avevo mai letto questo suo lavoro,
ma solo qualche breve trattato su specifici aspetti di divinità.
Così, avendo trovato online
Eterno femminino mediterraneo mi sono
decisa a leggerlo.
Ecco un sunto di ciò che contiene questo
volumetto, tenendo presente però, che a volte Pestalozza salta di
palo in frasca e non sempre sviluppa un discorso in maniera
organica.
L'autore cerca di ricostruire una ipotetica
religiosità pre-greca,
diffusa in buona parte del bacino del Mediterraneo, che potremmo dire
pre-indoeuropeo, concentrandosi in particolare sulla civiltà
Minoica, e sulle vestigia di questa religiosità rintracciabili nella
Grecia storica.
Questa religione, dice, era imperniata su una Dea
che chiama
Potnia, “la Signora”, il cui nome è stato trovato in
alcune tavolette micenee. L'elemento fondamentale della Potnia,
nascendo in una civiltà agricola che vedeva un'unità fra la
divinità e la Terra, era dare la vita. All'equazione
terra=dea, si aggiunge la donna, manifestazione umana della Potnia;
più vicina alla terra dell'uomo, in virtù di questa unità sarebbe
stata particolarmente attiva nell'agricoltura , e così anche prima
conoscitrice delle virtù curative delle piante.
Simboli della
Potnia minoica erano l'ascia bipenne, ipotizzato anche come strumento
agricolo, e la torcia, ereditato quest'ultimo da alcune dee
storiche, per cui il fuoco è anche simbolo di purificazione e
fecondità.
L'aratura prefigura la
mixis cioè
lo
hieros gamos, il matrimonio divino, per cui se
dea=terra=donna, l'unione sessuale sulla terra arata ne stimola la
fertilità. Oltre al solco terrestre anche alcuni fiori e frutti,
come il melograno, sono simboli dell'
aidoion, come lo chiama
l'autore, ovvero del sesso della Dea. Altra identità oltre a quella
dea=terra=donna, si ha con la luna che con il suo ciclo influenza
l'agricoltura, così come il mestruo. Il Sole, tanto glorificato
simbolo maschile nelle religioni storiche, in questo studio risulta
al servizio della Potnia, in quanto in grado di favorire la vita
vegetale.
La Potnia regna anche sul mare, oltre che su tutte le
espressioni terrestri: è legata alle grotte, ai pascoli (e quindi
gli armenti), ai campi e ai prati (e quindi al nutrimento e alle erbe
curative).
C'è nel pensiero religioso mediterraneo, dice
Pestalozza, una fluidità ed unità delle varie forme che rimandano
l'una all'altra, per cui la metamorfosi è avvertita come naturale,
non così nella mitologia greca per cui essa è spesso punizione o
dovuta ad un atto di pietà. Non esisteva dunque il senso di
sovranità dell'uomo sulla natura.
Mentre sono state trovate
rappresentazioni del sesso femminile, nella Creta minoica (a detta di
Pestalozza) mancavano segni fallici, ipotizza quindi che questi
fossero sostituiti dal serpente e dal corno. I greci al contrario,
rappresentavano il fallo ma non la vagina.
Le epifanie animali più
comuni della Dea erano quella taurina ed equina, ma essa era anche
vicina ai serpenti come la nota Dea dei serpenti cretese, legata
all'ambiente della reggia e quindi anche protettrice della
regalità.
In un certo momento, da essere metamorfico che si
presenta come animale, essa diventa la Signora degli Animali; ma è
anche la Dea Ape Melissa, che si collega alle sue epifanie vegetali,
e da qui alla forma di colonna o palo. Inoltre per tutti questi suoi
attributi, è anche conoscitrice delle erbe e quindi dei
pharmaka,
ovvero dei rimedi vegetali, secondo Pestalozza in particolare di
quelli usati per placare i dolori del parto, efficaci sia perché
medicina, sia perché pregni del potere della Dea, e da qui la
Potnia
pharmakides, "strega, maga" di cui resta traccia in Circe, Medea,
Pasife, Elena, per quanto non più divine.
Altra caratteristica
della Potnia è di essere senza madre e senza padre (attributo
mantenuto dalla Gaia greca), è autogenerante essendo per antonomasia
colei che da la vita, ma si unisce anche col
paredro “colui che
siede affianco”, essendo la sua unione portatrice di fertilità: da
qui l'istituzione, comune a varie zone mediterranee, della
prostituzione sacra, per cui le ierodule incarnavano la Potnia
ricreando lo
hieros gamos.
Inoltre la Potnia è
parthenos,
cioè vergine, sia nel senso che è autonoma, estranea a qualsiasi
violenza, libera, sia perché può riacquistare la verginità (come
alcune divinità olimpiche fanno bagnandosi in acque particolari).
La
figura dell'androgino originario viene scisso dunque questa grande Potnia
femminile e nel paredro, figlio e amante, che nel ciclo originario
muore e poi ritorna, così come il seme nella terra, come adombrano
(in maniera più o meno completa, ovvero più o meno
patriarcalizzata) i miti di Rea e dello Zeus cretese, Ishtar e
Tammuz, Isis e Osiris, Cibele e Attis. Tuttavia anche le Potnie
minori (ovvero quelle che nella mitologia greca non sono più Dee) a
volte muoiono; in ogni caso tutta questa serie di copie divine che
condividevano una hierogamia, lascia intendere la sacralità
dell'unione sessuale per i popoli mediterranei, ed il fatto che la
morte non fosse sentita come negativa e definitiva. Una traccia di
questa concezione è rimasta nell'idea dei Campi Elisi a cui gli
uomini giungevano dopo la morte. Questo ciclo escatologico sarebbe
ciò che in tempo storico ha portato ai noti Misteri Eleusini.
Segue
la bibliografia.
Per quanto riguarda lo
stile, ad un lettore
moderno risulta inevitabilmente piuttosto arcaico (è comunque un
testo pubblicato negli anni 50), a tratti poetico, a volte oscuro. Mi
ha fatto sorridere la capacità di trovare le più varie (e a volte
aggraziatissime) circonlocuzioni per non dire sesso, vagina e pene.
L'opera è corredata da alcune immagini che rappresentano alcuni
degli oggetti di cui parla l'autore; nota
negativa è il fatto che faccia molti rimandi a suoi scritti
precedenti, che non nomina mai, per cui a volte lascia delle
affermazioni inspiegate, inoltre quando cita altri autori non dà indicazioni a riguardo, a volte non dice neanche chi sta citando.
Per chi non conosca greco e latino, la lettura potrebbe essere
compromessa dal fatto che sono riportate frasi e parole prive di
traduzioni in italiano.
Passando al
contenuto, ho
apprezzato molto alcune delle sue teorie, e nella storia dello studio
delle religioni è stato sicuramente uno di coloro che hanno rotto la
visione totalmente patriarcale delle civiltà antiche, che non poteva
dare credito ad ere in cui le donne avevano prestigio, importanza, il
cui il femminile era sacralizzato.
Tuttavia, alcuni
collegamenti
mi sono sembrati piuttosto
forzati (a volte ho avuto difficoltà a
seguirli e a capire come secondo lui si collegasse una cosa ad
un'altra), l'impressione a tratti è stata che l'autore vedesse solo
quello che voleva vedere, ovvero solo gli elementi che potessero
avvalorare la sua tesi.
Inoltre il continuo sottolineare la
superiorità femminile, è sì, da una parte, un ribaltamento che dà
da pensare, dall'altro il porre il maschile in una posizione di
sottomissione e inferiorità mi sembra altrettanto negativo del
contrario.
Sicché trovo che sia un testo che può essere letto,
sia per il suo valore storico, innovativo per il suo tempo, sulla
religiosità matriarcale, sia per prendere coscienza di un modo
alternativo di sacralità e di conseguenza di società, tenendo
comunque presente il fatto che ad oggi esistono altri testi che
studiano le società matriarcali passate e presenti a livello
religioso, economico, sociale ecc. in maniera più chiara e
scientifica di questo; l
o consiglierei solo a veri appassionati
dell'argomento o a specialisti del settore.
Utilità
Potete scaricare in PDF o leggere on-line
Eterno femminino mediterraneo andando a
questa pagina del sito dedicato all'Autore.
Esistono varie raccolte degli studi di Pestalozza, tutte di difficile reperibilità e specialistiche, questo è sicuramente il testo più accessibile, insieme a
I miti della donna giardino.
Se ti è piaciuto questo libro potrebbero interessarti anche:
- I miti della donna giardino di Uberto Pestalozza
- Da Circe a Morgana di Momolina Marconi
- Le dee perdute dell'antica Grecia di Charline Spretnak
- Le dee viventi di Marjia Gimbutas