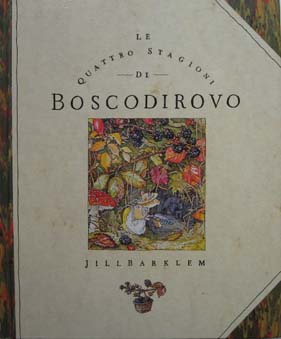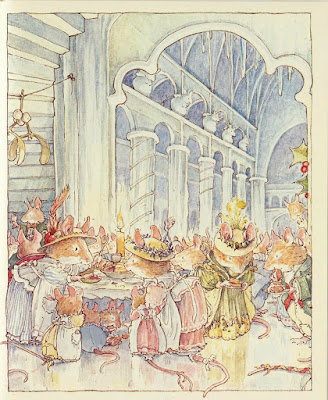Nostalgia del paradiso – Il giardino
medievale di Franco Cardini e Massimo Miglio, Laterza, 2018
Numero
pagine: 203
Lingua originale: italiano
Prima edizione:
2002
Genere: saggio
Avevo adocchiato questo libro già da
un bel po', ma ero indecisa sull'acquisto; avevo già letto
Giovanna
D'Arco di Franco Cardini, trovandolo piuttosto noioso, così alla
fine sono arrivata al compromesso di farmi regalare
Nostalgia del paradiso per
Natale.
Il libro tratta dell'
idea e della
forma del giardino
attraverso il
Medioevo, sia nella letteratura che nella sua forma
fisica. Dopo una breve introduzione degli Autori, il primo capitolo
tratta dell'eredità antica rielaborata in tempi medievali: modelli
letterari classici sono i giardini omerici e quelli di babilonia, ma
anche le descrizioni di quelli egizi e persiani, ma dal mondo
greco-romano provengono non solo testi poetici sul giardino, ma anche
trattati. I riferimenti culturali cristiani sono invece l'Eden,
l'
hortus del Cantico dei Cantici e l'orto di Giuseppe D'Arimatea.
Con
il passaggio all'Alto Medioevo si assiste ad un cambiamento anche a
livello paesaggistico: l'allevamento cresce a discapito
dell'agricoltura. Il
giardino dei monasteri (vengono citati in
particolare le abazie di S. Gallo e Cluny) erede del giardino della
villa rustica romana, riproduce simbolicamente quello dell'Eden, ha
sia utilità pratica, sia spirituale, prelude al paradiso, è diviso
in
pomaia (frutteti)
viridaria (giardino con alberi) e
herbaria. Ha
pianta a croce con al centro un pozzo o una fonte simbolo di Cristo,
oppure un albero che richiama l'Albero della Vita. Il giardino
medievale è
hortus conclusus, artificiale, virginale, è uno spazio
sacro e per tanto si differenzia dalla natura selvaggia, ha un
confine ed un guardiano.
Oltre agli autori classici più noti, in
questo capitolo vengono citati Rabano Mauro, Walafrid Strabo, Alberto
Magno ma anche S. Ildegarda ed il C
apitulare de villis di Carlo
Magno.
Il secondo capitolo che spazia nei secoli XI e XII, tratta
del rinnovamento dei giardini dovuto sia a cambiamenti materiali
(aumento delle temperature, aumento demografico e della qualità
della vita, crescita del commercio) sia culturali con nuove influenze
orientali soprattutto arabe (principalmente provenienti da Spagna,
Egitto, Sicilia) e persiane. Anche nel
Corano il giardino coincide
con il paradiso, inoltre gli arabi portano con loro grandi abilità
tecniche riguardanti irrigazione, innesto, architetturae e medicina.
Fra gli autori più importanti sono citati Ibn Juljul, Ibn Al-Baitar,
Ibn al-Awam e Ibn Luyun.
Il terzo capitolo prosegue il viaggio nel
XIII secolo: si assiste ad una nuova visione della natura e del
piacere (grazie alla scuola di Chartres, quella di Oxford e la
predicazione di S. Francesco). Nella letteratura cortese compare
spesso il giardino esso è inviolabile, eternamente fiorito e ricco
di piante magiche forse anche grazie all'innesto di motivi
provenienti dalla cultura celtica. Esempi si trovano nel
Roman de la
rose, nell'
Erec et Enide di Chrétien de Troyes, e nel
Floire e
Blanchefleur.
Il quarto capitolo affronta la prima parte del XIV
secolo: il giardino incarna la misura, il numero, la cultura,
appartiene alla città, non più alla natura, e diventa anche un luogo laico, uno dei luoghi dei potenti e simbolo di prestigio. Oltre
che nelle opere Dantesche, il giardino ha grande rilevanza negli
scritti di
Petrarca, il quale curò personalmente un proprio orto,
appuntando i lavori svolti (si tratta della prima testimonianza di
questo tipo a noi pervenuta).
Il quindo capitolo parla dei
cambiamenti avvenuti in seguito alla crisi economica, agricola e
sociale de XIV secolo, che vide la comparsa della Peste Nera. Il
giardino diventa l'ambientazione della Danza macabra e del memento
mori, e riveste un ruolo importante nelle opere di Boccaccio, i cui
modelli, oltre a quelli letterari, furono i giardini fiorentini,
simboli di potere, del bel vivere, ma anche luoghi di meditazione,
come quello della Certosa di S. Lorenzo a Firenze ad opera di Niccolo
Acciaiuoli, che fonde il classico giardino monastico con quelli dei
signori del tempo.
Il sesto e ultimo capitolo si spinge fino alla
fine del medioevo: il giardino unisce il bello e l'utile, ed il
passaggio dal giardino medievale a quello rinascimentali si avverte
chiaramente nei giardini papali. A Firenze il giardino urbano dei
signori diviene giardino filosofico, un artificiale luogo di letizia,
non più Eden cristiano ma luogo di riflessione
neoplatonico.
Chiudono il libro note, bibliografia, referenze
iconografiche, indice dei nomi ed indice generale. Ad intervallare il
testo si trovano molte bellissime illustrazioni a colori, tratte
principalmente da manoscritti.
Come si può vedere, si tratta di
un libro ricco di contenuti che spazia attraverso secoli di storia del giardino; gli Autori sono molto competenti e l'esposizione è piuttosto chiara, tuttavia, personalmente ho fatto fatica
a finirlo, non mi ha avvinto particolarmente, lo consiglio solo ai
veri appassionati della storia medievale e del giardino.